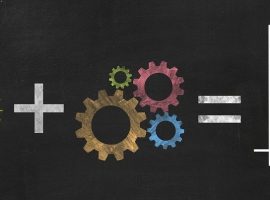Con quale atteggiamento ci siamo affacciati all’inizio del nuovo anno: paura o fiducia?
Il sentimento con cui affrontiamo il futuro, e niente più di un nuovo anno incarna l’idea di futuro, dipende dal rapporto che ciascuno di noi ha con il concetto di rischio.
Rischio è una parola ambigua. Può assumere un significato negativo, se associata all’idea di pericolo, ma porta con sé anche valori positivi: l’ebbrezza dell’avventura, l’energia, la libertà.
“Chi non risica non rosica” dice il proverbio. Il successo di un’azienda, ad esempio, si fonda in gran parte sull’accettazione del rischio d’impresa da parte dei suoi fondatori.
Non poi è un caso che i principali Sistemi di Gestione – Qualità, Ambiente, Sicurezza – abbiano scelto un approccio “risk based thinking”, che mette il concetto di rischio (e quello speculare di opportunità) al centro dell’analisi sui processi aziendali.
Rischio come effetto dell'incertezza sugli obiettivi
La norma ISO 31000 sul Risk Management parla di “rischio come effetto dell’incertezza in relazione agli obiettivi”, definizione che apre le porte al tema della misurazione e della valutazione statistica del rischio.
Se questo approccio razionale può funzionare a livello aziendale, a livello personale la valutazione del rischio dipende più da una percezione soggettiva che da analisi oggettive.
Le nostre scelte sono condizionate da bias o trappole cognitive (cosa sono i bias? ne abbiamo parlato qui) come l’overconfidence, il bias dello status quo, il bias di omissione, che spesso ci portano fuori strada.
Insomma, il rischio è un po’ come l’aria: ci viviamo dentro, in ogni momento della nostra vita, nel privato e sul lavoro. La domanda inevitabile è: come trovare un equilibrio nell’affrontarlo?
Rischio e pericolo non sono la stessa cosa
Intanto sgombriamo il campo da un malinteso: rischio e pericolo non sono sinonimi.
Il pericolo è rappresentato da un evento, una situazione, un oggetto o una sostanza che possono causare un danno di natura fisica oppure economica a persone, organizzazioni o cose.
Il rischio invece è la probabilità che questo danno si verifichi realmente.
Facciamo qualche esempio.
1. Un fulmine è un pericolo, il rischio è rappresentato dalle probabilità che ci colpisca.
2. Un cliente insolvente è un pericolo per la stabilità di un’azienda, ma il rischio coincide con le probabilità che tra i nostri clienti ci siano dei cattivi pagatori.
3. Un utensile tagliente è un pericolo ma il rischio è rappresentato dalle probabilità di tagliarsi se non si rispettano le misure di sicurezza.
Detto in altre parole: non possiamo in assoluto eliminare i pericoli ma possiamo quantificare i rischi e mitigare i danni attraverso dei comportamenti adeguati.
L’approccio “risk based thinking” nei Sistemi di gestione
Nel caso dei Sistemi di gestione l’approccio “risk based thinking” si fonda sostanzialmente su questa convinzione: per un’organizzazione l’analisi dei fattori interni ed esterni che rendono incerta la realizzazione dei suoi obiettivi è fondamentale nella pianificazione dei processi a tutti i livelli, da quelli strategici fino alle applicazioni operative.
In molti casi l’incertezza è determinata soprattutto da una mancanza di informazioni che rende difficili le decisioni e ci fa dire “E adesso, cosa facciamo”?
Nell’ambito della sicurezza sul lavoro la gravità dei singoli rischi viene classificata sulla base del rapporto tra la probabilità che un evento accada e l’entità dei danni che potrebbe produrre.
Un esempio di questo approccio è rappresentato dalle matrici di rischio (o matrici d’impatto o, ancora, matrici di probabilità) che utilizziamo per stabilire le priorità d’intervento e i livelli di precauzione da adottare in relazione alla gravità dei diversi pericoli potenziali.

Dalle aziende alle società, dalle società alle persone
Questo approccio, probabilistico e razionale, diventa molto più difficile da applicare a livello di società e di comportamenti individuali.
Nelle nostre società l’avversione per il rischio e la domanda di sicurezza sono sempre più diffuse e si applicano a una molteplicità di campi. Si parla con grande enfasi e preoccupazione di rischi ambientali, di rischi legali all’incertezza economica, di rischi legali alla salute o all’alimentazione, di rischi legati alla criminalità e così via… Inoltre, evocare un rischio, o peggio amplificarlo attraverso i media, è spesso una strategia politica o di marketing per esercitare un potere o vendere qualcosa.
In questi anni psicologia ha cercato di studiare come la percezione del rischio (spesso distorta, in un senso o nell’altro) condizioni i comportamenti individuali di fronte all’incertezza e concorra a orientare le decisioni.
Si è scoperto, ad esempio, che a parità di danno i rischi ci sembrano più minacciosi in due casi specifici:
1 .se ci vengono imposti e non sono liberamente scelti;
2. se hanno un impatto potenzialmente catastrofico (è il motivo per cui alcuni di noi temono di più un disastro aereo rispetto a un incidente automobilistico, in barba alle probabilità).
Come ci ingannano le trappole cognitive
Abbiamo già parlato in queste pagine dei bias cognitivi, scorciatoie della mente che ci danno l’illusione, solo l’illusione, di procedere razionalmente quando ci troviamo di fronte a una scelta difficile. Alcuni di questi inganni agiscono in forma ancora più potente di fronte a un potenziale rischio.
È il caso, ad esempio, del bias di conferma. Ne siamo vittime quando prendiamo in considerazione esclusivamente i dati e i fatti che confermano e sostengono le nostre opinioni, le ipotesi e i desideri cui tendiamo, e ci ostiniamo invece a trascurare ogni evidenza contrastante.
Parente stretto del bias di conferma è il bias dello status quo. Consiste nella tendenza a mantenere la condizione attuale, quale essa sia, sopravvalutando le possibilità di perdite connesse con un eventuale cambiamento e sottovalutandone i vantaggi.
Altrettanto insidioso il bias di omissione: quando ci sembra preferibile (e più eticamente accettabile) sbagliare per non aver fatto niente che sbagliare per aver fatto qualcosa. Quindi, nell’incertezza, risulta più facile (e sembra più giusto) non fare piuttosto che fare.
Di segno opposto all’immobilismo del bias di omissione, ma non meno diffusa, è l’overconfidence. Una condizione, tipica di chi è esperto, in cui l’eccessiva sicurezza che una persona ha dei propri mezzi e delle proprie abilità la porta a sottostimare l’entità oggettiva del rischio che ha di fronte.
Il rischio è anche libertà
In questa oscillazione tra valutazione razionale e percezione soggettiva del rischio, cosa possiamo dire per concludere?
Certo, saper analizzare, affrontare e ridurre i rischi è fondamentale, nel lavoro e nella vita. Eliminarli del tutto, invece, è impossibile.
Non solo esisterà sempre una componente di incertezza in tutte le attività umane ma talvolta questa imprevedibilità coincide con la nostra libertà, con la possibilità di cambiare il corso delle cose e disegnare un futuro diverso e migliore. Con fiducia e senza paura.